Iscriviti per ricevere una e.mail per ogni nuovo articolo pubblicato!
torna a RIONE Svago 🎡
Un itinerario agevole e ricco, tutto in 5 giorni di cultura, mare, cucina, città d’arte, ecc..
Punto di arrivo e luogo di riferimento per tutta la durata del viaggio;
| Cartolina di MONOPOLI (in dialetto Monopolitano) | |
|
Veduta di Monopoli dal mare |
Struttura consigliata:
Anna’s Rose 🥀 Holiday Home














1° GIORNO, visita alla città, conoscerne gli angoli più caratteristici e la sua storia! Monopoli, grande piazza bianca, dove tutte le case sono imbiancate a calce, come tutto il resto della città…
Cosa ha di speciale Monopoli? Un caratteristico centro storico di origine alto-medievale, sovrapposto ai resti di un abitato messapico fortificato già nel V secolo a.C., si affaccia sul mare circondato da alte mura.
Monopoli è anche detta la città delle cento contrade. L’agro infatti è diviso in varie località denominate contrade (sebbene il loro numero sia inferiore alle cento unità), i cui toponimi rievocano antichi casali scomparsi, la presenza di una masseria, di una chiesa o altri riferimenti storico-geografici.
È durante il Medioevo che la città di Monopoli conosce la sua massima espansione, tanto da inglobare i territori delle attuali città di Fasano, Locorotondo, Alberobello e Cisternino. Nel 1041 si svolge la cosiddetta battaglia di Monopoli tra Bizantini e Normanni con la prigionia di Exausto. La città si unisce all’insurrezione pugliese chiedendo l’aiuto dei normanni. Nel 1042 Bisanzio invia in Puglia il famoso e crudele generale Giorgio Maniace che si rivolge immediatamente contro la città ma, non riuscendo a prenderla, si accanisce sulle campagne e sui borghi rurali, con terribili stragi e crudeltà.
Nel 1045 Monopoli viene assegnata, ma solo sulla carta, a Ugo Toute-Bone nell’assemblea normanna di Melfi. Ugo però riesce a espugnarla solo nel 1049, ricorrendo all’interramento del porto canale che gli consente l’aggiramento delle forti difese terrestri. Successivamente la città, fedele a Federico II durante la sua minore età, subisce numerosi attacchi da parte dei baroni ribelli senza essere mai espugnata. Durante questi assedi le mura vengono notevolmente danneggiate e Federico II mostra riconoscenza ricostruendole e ampliandole.
All’inizio del XIII secolo si ambienta la romanzesca ma documentata storia di Maio di Monopoli un pirata monopolitano che, avendo ucciso una persona di rango elevato, fu costretto a fuggire da Monopoli a Cefalonia con un gruppo di seguaci. Riuscì a conquistare le isole ionie (Cefalonia, Corfù, Zante, Itaca) divenendone conte. Consolidò il proprio potere sposando nel 1226 Anna Angelo, figlia di Teodoro Angelo Ducas e di Zoe Ducas, potentissimi personaggi alla corte imperiale di Costantinopoli. Da lei ebbe due o forse tre figli, tra i quali il primogenito Giovanni e il secondogenito Riccardo, assassinato nel 1303. Sono documentati due suoi incontri con l’Imperatore Federico II. Non si conosce con certezza la data della sua morte avvenuta dopo il gennaio 1238
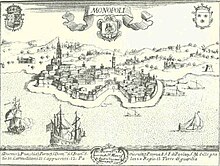
Monopoli, nella seconda metà del XIII secolo, conosce la dominazione degli Angioini, per poi sottomettersi a quella aragonese, con la quale Monopoli vive un periodo di ripresa che continua anche sotto la dominazione veneziana nel 1484. La città passa dopo pochi anni da Venezia in mano ai francesi. Memorabile, crudele e ben documentato è il sacco di Monopoli da parte della flotta veneziana, che riconquista la città in pochi giorni dopo violenti e sanguinosi combattimenti, attaccandola dal mare il 29 giugno 1495. Gli storici veneziani, in tale occasione, la descrivono del resto come una bellissima e ricca città. Dopo la presa di Otranto del 1480 da parte della flotta ottomana, per tutto il XVI e XVIII secolo la città conosce un periodo di grande tensione e preoccupazione (come del resto tutto l’Adriatico).
La città in realtà non è mai stata attaccata direttamente dalle flotte turche, che probabilmente la evitarono a causa delle sue poderose fortificazioni, fortemente presidiate. Sono ricorrenti tuttavia le scorrerie di singole navi di pirati algerini, che si limitano a rapire cittadini isolati fuori dalle mura per farli schiavi e quando possibile ricavarne dei riscatti. Nel 1529 la città, protetta dal suo efficacissimo sistema difensivo, con l’aiuto di soldati veneziani e grazie all’eroismo dei suoi cittadini, resiste vittoriosamente a tre mesi d’assedio da parte degli imperiali spagnoli al comando del marchese del Vasto Alfonso III d’Avalos, che è costretto a ritirarsi a causa delle importanti perdite. Dopo la pace con Venezia, la città passa pacificamente in mano a Carlo V d’Asburgo. Nel luglio del 1647, durante una rivolta popolare per una nuova tassa sul macinato, l’odiato governatore spagnolo viene linciato insieme ad un povero armigero che cerca di difenderlo. Alla fine di settembre tutto termina con una durissima repressione operata dalle truppe di stanza a Bari. Ad eccezione di questo episodio, dalla metà del Seicento in poi Monopoli segue le sorti del resto del Mezzogiorno, con le dominazioni dei Borbone, e quindi l’annessione al Regno d’Italia nel 1860.
2° GIORNO, visita a Alberobello, con 25 km e max 30 minuti di auto.
|
Cartolina di ALBEROBELLO (Aiarubbédde in dialetto) |
|
|---|---|
La storia di questi edifici molto particolari è legata alla Prammatica De Baronibus, un editto del Regno di Napoli del XV secolo che sottoponeva ad un tributo ogni nuovo insediamento urbano. I conti di Conversano D’Acquaviva D’Aragona da 1481, proprietari del territorio su cui sorge oggi Alberobello con la “domus” estiva che si chiamava Difesa De Le Noci al confine con il territorio del ducato di Martina Franca, imposero allora ai contadini inviati in queste terre di edificare a secco, senza utilizzare malta, le loro abitazioni, in modo che esse potessero configurarsi come costruzioni precarie, di facile demolizione.
Dovendo quindi utilizzare soltanto pietre, i contadini trovarono nella forma rotonda con tetto a cupola autoportante, composto di cerchi di pietre sovrapposti, la configurazione più semplice e solida. I tetti a cupola o mezzo cono per la paglia detta falsa cupola dei trulli sono abbelliti con pinnacoli decorativi che rappresentava come dicono molti il pinnacolo era la firma del maestro trullaro che lo faceva o che restaurava e rappresentava la posa del pinnacolo un momento emozionante, la cui forma è ispirata a elementi simbolici, mistici e religiosi profani ma che appaiono soprattutto nel periodo fascista.
Trullo sovrano Corte di Papa Cataldo
Il trullo più grande è chiamato Trullo Sovrano situato in piazza Sacramento (in onore della confraternita), alto circa 14 m, nome ufficiale dato da Giuseppe Notarnicola nel 1916. Fatto costruire dalla famiglia Perta da Monsignore Don Cataldo Perta (nato 1744-deceduto 1809) alla metà del Settecento e anche fatto nel 1780, nell’Ottocento è sede della confraternita del Santissimo Sacramento (1823-1974) dal 1826 al 1837 e della confraternita dei Santi Medici (1839-1974) nel 1840, ecco perché all’ingresso fu raffigurato un dipinto del Calvario di artista ignoto. Si dice che ospitò la reliquia dei Santi Medici .Questo edificio a due piani fu restaurato negli anni ’90 è adibito a museo ed è possibile visitarne l’interno con prezzo d’ingresso, arredato secondo il gusto d’epoca, ricostruito tramite le testimonianze dei più anziani abitanti alberobellesi. Durante il periodo estivo, il Trullo Sovrano ospita manifestazioni quali spettacoli teatrali, concerti di piccole orchestre o formazioni Jazz, serate di cultura e poesia e di beneficenza e viene anche colorato con fari di luce. In passato, dope e doppio è il trullo Paparale del Seicento che si trova in periferia.
Casa Pezzolla Museo del Territorio
In una zona centrale dell’abitato compresa fra il quartiere storico Aia/Aja Piccola e Piazza del Popolo dal 1922 (ex piazza della Vittoria o Vittorio Emanuele II) sorge il più grande complesso di trulli contigui e comunicanti (quindici) visitabili ad Alberobello, tra i più antichi dei quali risalgono al XVIII secolo. Tale complesso abitativo, identificato come Casa Pezzolla dal nome degli ultimi proprietari, è stato acquistato dal Comune di Alberobello nel 1986 e restaurato tra il 1993 e il 1997.
Nel complesso a trulli si distinguono due tipi di tessuto edilizio: uno che si affaccia interamente su piazza XXVII Maggio detta l’Aia Grande (ex piazza delle erbe) e, con un effetto prospettico monumentale, si sviluppa su due piani, con facciata alta e stretta sormontata da un timpano triangolare che evidenzia la sezione del tetto a due falde, coperto da chiancarelle. L’altro tessuto rappresenta la parte più antica e risente dell’influenza della zona monumentale dell’Aia/Aja Piccola.
Il complesso di Casa Pezzolla ospita il Museo del Territorio, un’esposizione museale permanente, divisa in aree tematiche e cronologiche, per fornire informazioni complete riguardanti il territorio e esposizione di progetti e di concorsi.
3° GIORNO, visita alla città di Matera (Basilicata), con 80 km e un’ora e 15 minuti di auto.
| Cartolina di MATERA (Matàrë in dialetto materano) | |||
|---|---|---|---|
|
|||
Matera è nota con gli appellativi di “Città dei Sassi” e “Città Sotterranea“, è conosciuta per gli storici rioni Sassi, che fanno di Matera una delle città ancora abitate più antiche al mondo. I Sassi sono stati riconosciuti il 9 dicembre 1993, nell’assemblea di Cartagena de Indias (Colombia), Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, primo sito dell’Italia meridionale a ricevere tale riconoscimento.
Nel 1663 fu separata dalla Provincia di Terra d’Otranto, di cui aveva fatto parte per secoli, per divenire, fino al 1806, capoluogo della Basilicata nel Regno di Napoli. Durante questo periodo la città conobbe un’importante crescita economica, commerciale e culturale. Matera è stata la prima città del meridione a insorgere in armi contro il nazifascismo ed è per questo tra le città decorate al valor militare per la guerra di liberazione essendo stata insignita nel 1966 della Medaglia d’argento al valor militare e tra le città decorate al valor civile essendo stata insignita nel 2016 della Medaglia d’oro al valor civile.
Il 21 novembre 1954 è stata proclamata, con delibera comunale, Civitas Mariae. Papa Giovanni Paolo II la visitò il 27 aprile 1991, definendola città della Visitazione e del Magnificat. Il 17 ottobre 2014 Matera è stata designata, insieme a Plovdiv (città sita in Bulgaria), Capitale europea della cultura per il 2019.
Le origini di Matera sono molto remote e ne è testimonianza il ritrovamento nel territorio circostante di alcuni insediamenti senza soluzione di continuità sin dall’età paleolitica. Infatti nelle grotte sparse lungo le Gravine materane sono stati ritrovati diversi oggetti risalenti a quell’epoca, testimonianti la presenza di gruppi di cacciatori. Nel periodo Neolitico gli insediamenti diventarono più stabili, tanto che sono presenti tracce evidenti di diversi villaggi trincerati che risalgono a quel periodo, in particolare sulla Murgia Timone. Con l’Età dei metalli nacque il primo nucleo urbano, quello dell’attuale Civita, sulla sponda destra della Gravina. Sorta su un preistorico villaggio trincerato, questa, ha probabili origini greche, come afferma il Volpe nelle sue Memorie storiche profane e religiose sulla città di Matera,
Secondo alcune ipotesi, Matera anticamente veniva chiamata Mataia ole dai Greci, che deriva da Mataio olos, il cui significato è tutto vacuo. Ulteriore ipotesi è che il nome derivi da Mata (cumulo di rocce), radice utilizzata per diversi nomi geografici. Un’altra teoria, piuttosto fantasiosa, fa derivare Matera dal greco Meteoron ovvero cielo stellato, dato che alcuni cronisti del passato, osservando i Sassi illuminati di notte, li hanno descritti come un riflesso del cielo stellato soprastante. E non manca chi ricollega il toponimo a Mater ovvero “madre terra”, a Materia (matheria) o Materies, termini che indicavano la legna da taglio o da costruzione, in riferimento alle zone boschive in cui la città sorgeva.
Tradizioni e folclore

La festa patronale della Madonna della Bruna si celebra il 2 luglio di ogni anno sin dal lontano 1389, quando il Papa Urbano VI, già arcivescovo di Matera, istituì la festa della Visitazione, e va ricordata per la tradizione della distruzione di un carro trionfale di cartapesta che ogni anno viene ricostruito.
La tradizione del Presepe vivente nei Sassi di Matera, iniziata negli anni settanta grazie al Gruppo Teatro Matera e successivamente interrotta per molti anni, è ripresa nel dicembre 2010 con l’evento promosso dall’Unione Nazionale delle Pro loco d’Italia e dalla Regione Basilicata. Con la partecipazione di diverse centinaia di figuranti su un percorso di 700 metri, è considerato il più grande presepe vivente al mondo. Sempre nei Sassi ha luogo una Via Crucis.
Il primo di agosto si festeggia la crapiata, zuppa di legumi e cereali, per festeggiare il raccolto dell’annata; un tempo svolta nei Sassi, oggi si festeggia nel borgo La Martella.
Per i festeggiamenti carnascialeschi sono di tradizione le matinate, canti popolari di questua in cui si portava musica e allegria in casa di parenti e conoscenti.
4° GIORNO, visita a Castellana Grotte con 15 km e 15 minuti di auto.
|
Cartolina di CASTELLANA GROTTE |
|
|---|---|
Le Grotte di Castellana sorgono a meno di due chilometri dall’abitato nelle Murge sud orientali a 330 m s.l.m., altopiano calcareo formatosi nel Cretaceo superiore circa novanta – cento milioni di anni fa. La visita turistica si snoda lungo uno scenario affascinante per 1,5 km. L’itinerario più lungo, richiede due ore e si sviluppa per 3 km, tra caverne e voragini dai nomi mitologici o fantastici. L’ingresso naturale è costituito da un’enorme voragine a cielo aperto, profonda una sessantina di metri, denominata la Grave. Dalla Grave alla Grotta Nera o della Lupa Capitolina, dopo aver superato il Cavernone dei Monumenti, superato la Calza e successivamente la Caverna della Civetta, attraversato il Corridoio del Serpente, la Caverna del Precipizio e il Piccolo Paradiso, si scorre per il lungo Corridoio del Deserto detto anche il Grand Canyon sotterraneo (di una colorazione rossiccia dovuta alla presenza in tale tratto di minerali ferrosi) si raggiunge la Caverna della Torre di Pisa, il limpido Laghetto di acqua di stillicidio, il Corridoio Rosso, la Caverna della Cupola e infine passando dal luccicante Laghetto di Cristalli, si giunge nella straordinaria Grotta Bianca, definita la più bella grotta del mondo, luminosa e splendente. Tutto costituito da splendide concrezioni stalattitiche e stalagmitiche e da gallerie intercalate dall’aprirsi improvviso di stupende caverne.
5° GIORNO visita alla città di Lecce un’ora e 15 minuti di treno (Monopoli-Lecce, solo seconda classe, interregionale ogni ora, € 8,00+8,00 a/r)
| Cartolina di LECCE (Lécce in salentino, Lupiae in lingua latina, Luppìu in griko) | |
|---|---|
Città d’arte d’Italia, è nota come “la Firenze del Sud”, “la Firenze dell’epoca del Rococò” o “la Signora del Barocco”: le antichissime origini messapiche e i resti archeologici della dominazione romana si mescolano infatti alla ricchezza e all’esuberanza del barocco, tipicamente seicentesco, delle chiese e dei palazzi del centro, costruiti in pietra leccese, un calcare malleabile e molto adatto alla lavorazione con lo scalpello. Lo sviluppo architettonico e l’arricchimento decorativo delle facciate è stato particolarmente fecondo durante il Regno di Napoli ed ha caratterizzato la città in modo talmente originale da dar luogo alla definizione di barocco leccese.
È stata tra le sei città italiane candidate a Capitale Europea della Cultura per l’anno 2019 nonché Capitale italiana della cultura nel 2015. Al 2016, tra le città della Puglia è quella che registra il maggior numero di arrivi e presenze turistiche, seconda solo a Napoli nell’Italia peninsulare del Sud.
La nascita della città di Lecce si può far risalire ad un’epoca antecedente a quella di Roma in quanto pone le sue radici già nell’età messapica. Il primo insediamento fu fondato dalle popolazioni provenienti dall’Illiria durante le migrazioni del III millennio a.C. e conosce il periodo di maggiore maturità nel VII e IV secolo a.C. Una leggenda vuole però che la città sia nata intorno al 1200 a.C., per opera di Malennio, subito dopo la distruzione di Troia, e che lui sarebbe stato il primo a dominare in quest’area e a introdurre la cultura greca nella città, allora chiamata Sybar.
Nel III secolo a.C. Roma conquistò tutto il Salento, quindi anche Sybar, che aveva mutato il nome in Lupiae, e la vicina Rudiae, città dove era nato il poeta Quinto Ennio che, negli Annales, cantò sei secoli di storia di Roma, a partire dall’arrivo di Enea sulle coste laziali. Tra la fine dell’età repubblicana e gli inizi dell’età imperiale, Lupiae si presenta cinta da mura, costruite su quelle messapiche, dotata di un foro, un teatro ed un anfiteatro ed uno sbocco sul mare: porto Adriano, l’attuale marina di San Cataldo.
All’età neroniana si vuole risalga l’evangelizzazione di Lupiae ad opera del patrizio Publio Oronzio che, convertito al Cristianesimo da Giusto, discepolo di san Paolo, sarebbe stato il primo vescovo e il primo martire della città.
Età medievale
Dopo una breve parentesi di dominazione greca, fu saccheggiata da Totila, re ostrogoto, nel 542 e nel 549 e rimase sotto il dominio dell’Impero Romano d’Oriente per cinque secoli, offuscata dalla potente Otranto, capitale del dominio bizantino. Successivamente, dal VI secolo in poi, si avvicendarono i Saraceni, i Greci, i Longobardi, gli Ungari e gli Slavi.
Fu la conquista normanna a far rinascere Lecce, quale centro commerciale, ed estese il suo territorio sino a diventare capoluogo del Salento. Infatti, a partire da Goffredo (1069) i conti normanni vi tennero corte e qui nacque l’ultimo re normanno, Tancredi, figlio di Ruggero III. Ai Normanni seguirono gli Svevi di Federico II e gli Angioini.
Età moderna
Dal 1463 fu soggetta al Regno di Napoli sotto la monarchia di Ferrante d’Aragona, che trasformò Lecce in “Sacro Regio Provinciale Consiglio Otrantino”, facendole acquistare sempre più importanza fino a divenire una delle più ricche e culturalmente vive città mediterranee. In questo periodo si sviluppò nei traffici commerciali coi mercanti fiorentini, veneziani, greci, genovesi, albanesi e fu importante centro culturale.
Nel XV secolo ebbero particolare fortuna le sue attività commerciali. Nei due secoli seguenti il Salento fu a più riprese minacciato dalle incursioni turche, tanto che sotto il regno di Carlo V la città fu dotata di una nuova cinta muraria e di un Castello e dell’attuale Porta Napoli.
Il 1630 fu l’anno in cui si diede il via alla costruzione di moltissime strutture religiose. In epoca spagnola la città si trasformò in un vero e proprio cantiere a cielo aperto, per le tante opere civili e religiose, che privati, clero, congregazioni ecclesiastiche, si diedero da fare per erigere; in un crescendo di opere sempre più belle ed importanti.
Una tremenda epidemia di peste funestò Lecce nel 1656. Le vittime furono migliaia e la tradizione religiosa narra che, dopo tanta attesa, avvenne un miracolo per intercessione di sant’Oronzo, che fu poi, per questo, proclamato patrono della città. Precedentemente la patrona era santa Irene.
Nel 1734, dopo la breve dominazione austriaca, a seguito del pericolo di una restaurazione spagnola, prende il potere la nobiltà. Nel 1821 Lecce partecipò al moto carbonaro e mandò un esercito di resistenza alle truppe austriache. Nel 1848 si formò un governo provvisorio e fu fondato il partito Liberale: durante questi anni sottoscrisse il memorandum delle Province Confederate e partecipò al moto liberale del Meridione. Dopo l’Unità d’Italia, in particolare tra il 1895 ed il 1915, la città conobbe una notevole attività edilizia con la realizzazione di numerose opere pubbliche e la prima espansione fuori dalle mura. Vengono creati nuovi quartieri in stile neoclassico, neomoresco e neogotico.
Cucina tipica Salentina
Il Salento ha una tradizione culinaria del tutto peculiare. In primavera e in estate i piatti sono prevalentemente a base di verdura e pesce, mentre nella stagione invernale, la pasta fatta in casa e i legumi sono al centro delle ricette del salento. È una cucina particolarmente povera per gli ingredienti usati, come la farina poco raffinata o l’orzo, ma che danno vita a piatti assolutamente unici.
Fra questi ciceri e tria (pasta fritta e ceci), pezzetti di cavallo al sugo, purea di fave e cicorie, orecchiette e cavatelli alla ricotta forte, sagne scannulate (attorcigliate), cicorie spritte, pomodoro spritto, rape affogate, friselle al pomodoro, paparina con le olive, lampascioni (cipolle selvatiche), pettole (polpette di pastella fritta), i moniceddhi (lumachine), la scapece (pesciolini fritti sott’aceto), il polipo alla pignata, cozze riso e patate, i turcineddhi (involtini di interiora), il sanguinaccio, la pitta (torta di patate ripiena), il rustico leccese con la besciamella, il calzone fritto, la puccia con le olive nere, friselle e taralli di ogni genere.
Per quanto concerne i dolci, nel Salento regna la pasta di mandorla, che assume diverse forme a seconda del periodo dell’anno. Tipica anche la cotognata, ovvero la marmellata di mele cotogne, cosi come quella d’uva, i purcedduzzi (piccole palline di pasta fritta girate nel miele), i mustazzoli (biscotti a base di mandorla, cacao ed altri aromi), il pasticciotto (pasta frolla e crema pasticciera) ed il fruttone, variante ripiena di marmellata e pasta di mandorla, la cupeta, lo spumone(gelato stratificato alla nocciola, cioccolato o pistacchio) e le pittedde (biscotti con la marmellata di cotogna e d’uva).
In sintesi, se andate nei ristoranti tipici, provate uno di questi piatti: orecchiette con le cime di rapa, la carne di cavallo, la cicoria con il purè di fave, riso patate e cozze, la focaccia alla barese, pittule, pasticciotti e rustici. Tipiche della zona di Bari, condite con le cime di rapa, vengono consumate anche nel Salento, condite con sugo di pomodoro e ricotta forte.
SE TI È PIACIUTA QUESTA PAGINA
CLICCA SU “MI PIACE”










